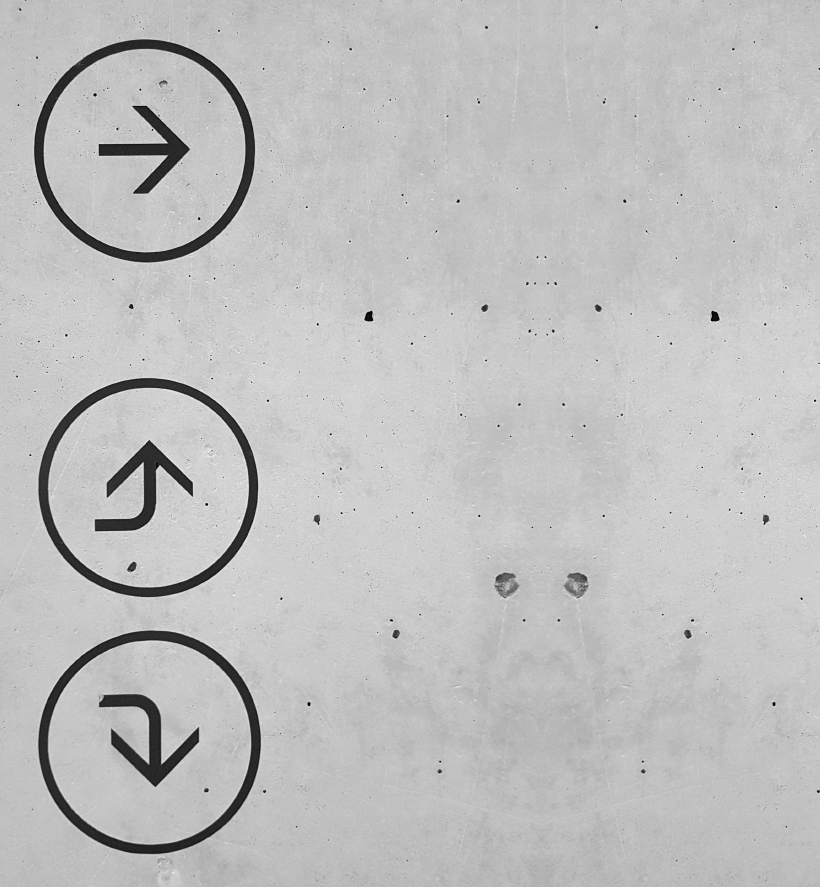A distanza di oltre tre settimane dalla pubblicazione, l’articolo 14 del Decreto Rilancio continua a essere oggetto di un inteso dibattito dottrinale.
La proroga del divieto di licenziamento per motivo economico sconta infatti una formulazione tutt’altro che felice che ha innescato dubbi, perplessità e interpretazioni contrastanti.
Il divieto, infaatti, opererebbe secondo un nuovo meccanismo che individua specifiche deroghe e che per il resto agirebbe – il condizionale è d’obbligo – armonicamente alle scelte dell’imprenditore in relazione alla prosecuzione della Cassa Covid e all’utilizzo (alternativo) dell’esonero contributivo introdotto dal nuovo decreto.
Nei casi in cui l’azienda decida di ricorrere a uno di questi due strumenti il divieto estende la propria ultrattività per tutta la durata della Cassa o dell’esonero; su questo aspetto il decreto non pare faccia sorgere particolari dubbi.
Le nuove norme, tuttavia, non chiariscono affatto un aspetto fondamentale della disciplina, ovvero se il divieto operi anche nel caso in cui l’azienda decida di non ricorrere ad alcuno degli strumenti di sostegno appena menzionati.
Non è chiaro, in particolare, se in queste ipotesi l’imprenditore sia comunque tenuto al rispetto del regime vincolistico speciale dei licenziamenti o se la decisione di affrancarsi dal sostegno statale lo renda libero dal divieto e, dunque, consenta di recedere per motivo economico dai rapporti di lavoro (nel rispetto, comunque, delle norme e dei principi generali del nostro ordinamento).
La questione non è di poco momento ed è destinata a creare impasse.
Il nodo interpretativo, in particolare, risiede nella lettura dei primi due commi dell’articolo 14, che precludono l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo previste dalla L. n. 223/1991 e la possibilità di recedere per motivo oggettivo dal contratto di lavoro “[A]i datori che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 […] ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto”.
La formulazione, come detto, ha acceso due contrastanti interpretazioni.
Da un lato, invero, è stato ipotizzato che vi sarebbe una strettissima connessione tra proroga del divieto e Cassa Covid/esonero contributivo, disegnata per limitare la facoltà delle aziende di riorganizzare, e di licenziare in genere, finché abbiano la possibilità di attingere a fondi dello Stato. Il divieto, in altre parole, tradirebbe (nel senso latino del termine) la volontà del Governo di coinvolgere direttamente le aziende nella protezione dell’occupazione, garantendo loro un supporto economico alla limitazione. L’alveo del divieto di licenziamento sarebbe così indipendente dalla scelta di ricorrere alla Cassa o all’Esonero contributivo e opererebbe in ogni caso.
Questa autorevole lettura si confronta con una diversa ed altrettanto prestigiosa tesi, secondo la quale, invece, la proroga del divieto non sarebbe generalizzata e dipenderebbe dalla decisione della singola azienda di ricorrere o meno agli aiuti regolati dal Decreto Rilancio: la rinuncia al sostegno statale, in sintesi, determinerebbe la cessazione del divieto.
In questa prospettiva, la ratio delle norme contenute nel Decreto Rilancio non sarebbe quindi quella di imporre un “baratto” indiscriminato tra strumenti di sostegno finanziati dallo Stato e limitazione alla facoltà di licenziare quand’anche l’azienda rinunci ai primi. È stato evidenziato, infatti, che la disciplina di questi strumenti si esprime in termini di possibilità e non di obbligo, sicché una lettura costituzionalmente orientata dovrebbe condurre alla conclusione secondo la quale l’imprenditore che decida di non ricorrere ad essi non si sottoporrebbe al “patto” con lo Stato per mantenere inalterati i livelli occupazionali.
A prescindere dagli orientamenti appena descritti, come detto entrambi autorevoli e degni di nota, è evidente che il dubbio interpretativo potrà essere sciolto definitivamente solo dopo un pronunciamento della magistratura del lavoro, o forse più pronunciamenti, per comprendere esattamente quale sia il perimetro integrale di questo importantissimo divieto.
Questa constatazione, tuttavia, porta l’articolo 14 del Decreto Rilancio verso un tema a mio avviso di capitale importanza: quello della chiarezza delle norme, che si traduce in efficienza del sistema e ha un impatto economico su tutti noi.
Dobbiamo infatti arrenderci all’evidenza del fatto che gli interpreti e le aziende devono affrontare una disciplina per alcuni versi volutamente oscura, che apre scenari alternativi e non aiuta a comprendere come lo Stato voglia che vengano gestite alcune delicate situazioni: tutto questo causerà paura, impasse e, in ultima analisi, mancanza di un vero rilancio.
Il Governo, infatti, non si è preoccupato di indicare con chiarezza ciò che si può fare e di distinguerlo, con altrettanta semplicità, da ciò che invece non si può fare non accedendo ulteriormente alla Cassa Covid (o all’esonero contributivo). Questo, seppur possa apparire banale, è un problema basilare da risolvere.
Il fatto che sulla estensione del divieto di licenziamento, per quanto detto, autorevoli lavoristi non abbiano identità di vedute, comunque la si voglia vedere, è certamente indice del fatto che le norme dell’articolo 14 non potranno creare certezza. In questo senso è ovvio annotare dunque come il ricorso alla giustizia dovrebbe essere lo strumento per dirimere i conflitti e non per supplire, ex post, a deficienze organiche di norme che sono nate per essere imperfette.
Se questo troppo spesso oramai accade significa che uno degli attori del sistema non ha ricoperto a dovere il proprio ruolo, che è quello di fornire norme che siano anche di facile applicazione (almeno per gli interpreti del diritto), senza demandare deleghe interpretative che lo deresponsabilizzino, lasciando che altri risolvano problemi non adeguatamente regolati.
Questo, è bene precisarlo, non perché il ricorso ai tribunali costituisca il male di un sistema – tutt’altro – ma perché inevitabilmente questa attività comporta tempi, costi e oneri per la collettività (e anche per le imprese) che potrebbero sicuramente essere evitati da norme più intellegibili.
Un recente articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica ha messo in evidenza, a tal proposito, un dato economico che ritengo illuminante: se il nostro sistema di giustizia civile si adeguasse ai tempi del sistema tedesco, l’Italia potrebbe ottenere un aumento di Pil di circa 40 miliardi di euro. È chiaro che regole come quelle che oggi commentiamo non contribuiranno certo ad aiutare il nostro sistema in questo senso.
Questo è un altro dato fondamentale che dovrebbe iniziare ad essere valutato; mi pare fin troppo evidente che non ci può essere rilancio quando le aziende devono decidere di sottoporsi a un vaglio giudiziale per sapere se la scelta di licenziare senza aver fruito della Cassa Covid o dell’esonero contributivo sia stata corretta. E non ci potrà mai essere rilancio davanti all’incertezza, che comporta attesa e non ripartenza.
In quest’ottica pare scontato dire come non saranno necessari particolari poteri divinatori per comprendere che molti imprenditori, a prescindere, preferiranno attendere il 31 dicembre 2020 prima di licenziare; non dimentichiamo infatti che la sanzione per la violazione del divieto dell’articolo 14 sarebbe la reintegrazione del lavoratore licenziato per averlo estromesso in violazione di un divieto di legge.
Quindi, la paura sarà la chiave di lettura vincente dell’articolo 14 del Decreto Rilancio, bloccando sul nascere qualsiasi iniziativa delle aziende che non utilizzino aiuti di Stato; ciò nonostante, ad oggi, nessuno possa affermare con granitica certezza che la scelta di licenziare sia vietata in simili ipotesi.
A ben vedere è sinceramente paradossale che tutto ciò debba avvenire in un simile momento storico e con riferimento a norme che sono contenute all’interno di un Decreto che è stato intitolato usando il sostantivo “Rilancio”
Per questi motivi l’articolo 14 del Decreto Rilancio, a prescindere dalle soluzioni tecniche che sono state proposte e che prevarranno, si presta ad un giudizio complessivamente negativo, così come altri interventi che si sono susseguiti in questi mesi in tema di lavoro.
Le norme, soprattutto quelle in tema di licenziamento, per definizione non sono favorevoli alle aziende: la loro funzione, infatti, è regolare interessi che sono contrapposti anche sulla base dei rapporti di forza tra i soggetti coinvolti.
Una norma non favorevole è però il male minore rispetto a una norma oscura, destinata invece a creare disfunzioni, dispersioni di tempo e di risorse con indubbia ricaduta in costi e perdite, anche economiche.
La certezza delle norme ha un valore strategico e non dovrebbe essere ulteriormente sacrificata. Da essa dipendono la capacità decisionale delle nostre imprese e, perché no, la possibilità del nostro Paese di rilanciarsi anche mediante investimenti stranieri.
Soprattutto perché, è bene ribadirlo, l’articolo 14 proroga un divieto speciale, che da oltre 6 mesi opera in aggiunta a un apparato normativo che norma già esaustivamente la facoltà di recesso del datore di lavoro.